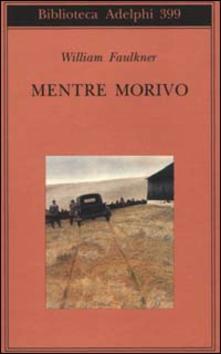
Che cos’è una radice? È la base. Un brodo primordiale da cui sgorga tutto il resto. È la parte più vecchia di ogni novità. Il punto meno visibile di ogni appariscenza. Ecco, tra le basi della letteratura moderna, inerpicata tra i pilastri di quelle opere recenti che ci piacciono tanto, siede un uomo chiamato William Faulkner. Tra le mani, stringe un volumetto dalla mole leggera e dal titolo ipnotico: “Mentre morivo”.
Pubblicato nel 1930 e passato sostanzialmente inosservato negli anni successivi come il celebre predecessore “L’urlo e il furore“, il lavoro di Faulkner riscrive i canoni della narrazione contemporanea, introducendo una serie di elementi che, debitamente diluiti, filtreranno attraverso centinaia di opere successive.
Trama di Mentre morivo
“Mentre morivo” ha come protagonisti i Bundren. Contadini da generazioni, indissolubilmente legati alla terra, i membri della famiglia presentano tutti caratteristiche uniche e peculiari. La storia, che più che accadere sembra essere già accaduta, narra del viaggio che Anse, Cash, Darl, Jewel, Dewey Dell e Vardaman intraprendono per seppellire Addie Bundren, moglie del primo e madre di tutti gli altri.
La donna vuole infatti essere sepolta a Jefferson, distante parecchi giorni dalla contea di Yoknapatawpha, luogo in cui vivono, oltreché parto della mente di Faulkner. L’intero viaggio, infarcito di simbolismi, porrà i Bundren davanti ad una serie di ostacoli, a volte allegorici, a volte pratici.
Recensione
Come detto, in “Mentre morivo” non è la trama a rappresentare il centro, ma l’intreccio. Faulkner rifiuta il ruolo classico del narratore, incastonando l’incedere in una serie di piccoli monologhi dove a parlare saranno i personaggi. È la logica, oggi molto ben conosciuta, del punto di vista, che qui però assume tratti meno accessibili o evidenti. I protagonisti, infatti, parlano tra sé, annaspando o mormorando. Gli eventi vanno intuiti leggendo tra le righe. L’unico personaggio che in qualche modo replica il ruolo dell’autore è Darl, titolare del più alto numero di monologhi.
È proprio durante i suoi spazi che Faulkner si abbandona ad una serie di descrizioni dal valore incalcolabile, spesso utilizzando frasi non sempre comprensibili, talvolta ermetiche, ma che rendono, appena assimilate, l’immagine perfetta e immodificabile. Gli intermezzi più complessi sono probabilmente quelli del piccolo Vardaman, che si abbandona facilmente a delle espressioni ricorrenti, oniriche, quasi ossessive, che assumono un senso soltanto una volta compreso il complicato quadro di insieme.
“Mentre morivo“ è un’opera corale. Un gigantesco apparato di morte e desolazione tra cui si insinua, strisciando nei campi, il fantasma pallido della vita. Non è un romanzo da leggere con distrazione, né una storia da assimilare di fretta parola per parola. Bisogna calarsi nell’atmosfera, conoscere i personaggi apparentemente stralunati, scavando nel loro essere fino a trovare quel nucleo fatto di strabiliante umanità. Bisogna leggere, rileggere e poi leggere ancora. Nonostante la sua difficoltà sia inferiore ad opere come “L’urlo e il furore”, possiamo garantirvi che difficilmente troverete 220 pagine più lunghe di queste.

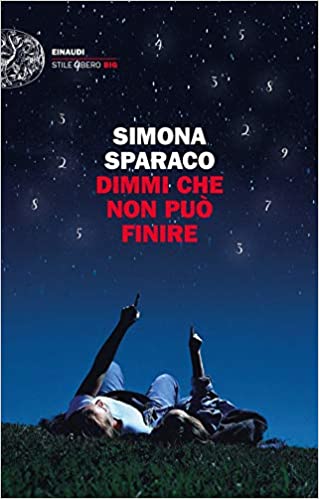
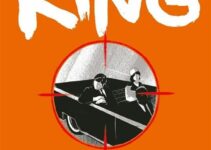
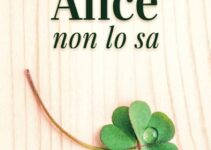
ho apprezzato la struttura innovativa, pluriprospettica, ma mi ha messo seriamente in difficoltà la prosa che fernanda pivano definisce con bontà “oscura”.
è stata una prova dura, che non sono sicura di aver superato…
Io ho impiegato tre letture (le ultime due praticamente di seguito) per “sintonizzarmi” con la prosa. Da un lato è fastidioso il fatto che una lettura non basti, anche perchè ci sono capolavori che invece risultano immediatamente cristallini. Dall’altro, ammetto che la gratificazione che si prova dopo aver “ricostruito” tutto non ha paragoni.