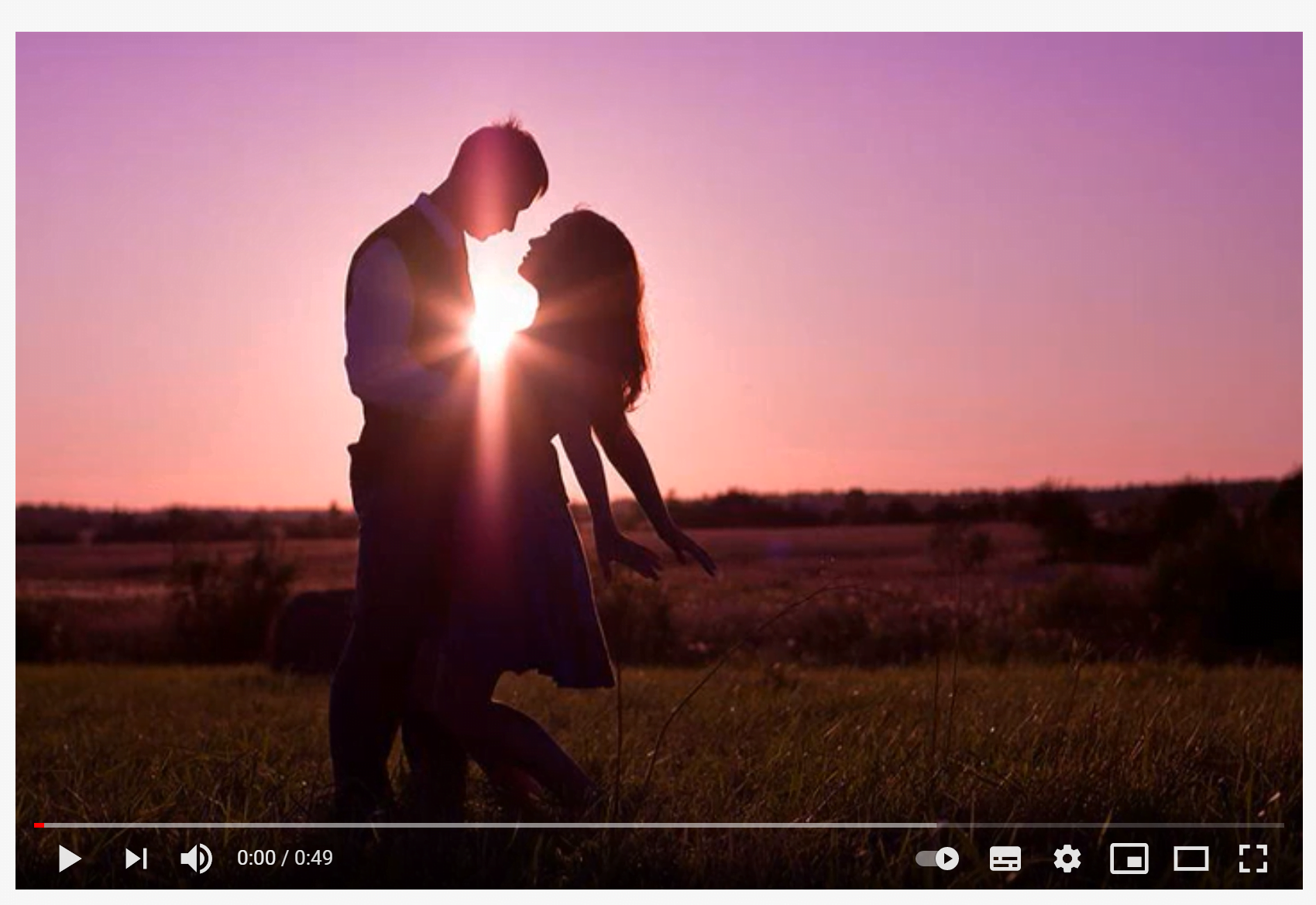– E quella là, che roba sarebbe?
Che qualcuno passasse sul sentiero davanti alla casa era un fatto talmente raro che si era bloccata di colpo, le braccia appoggiate alla zappa.
Si era schermata dal sole accecante di luglio portando una mano alla fronte, per scoprire chi avesse posto la domanda, con quella voce raschiosa, di carta vetrata. Appena al di là del muro di sassi, un ometto. Vecchio, decisamente vecchio, ora che riusciva a metterlo a fuoco. Una barba folta che sembrava fare tutt’uno coi capelli bianchi, sul viso grinzoso due occhi insospettiti, un braccio proteso nella sua direzione ad indicare “la roba” di cui si stava occupando, l’altro piegato a sostenere un cesto da dove sbucavano degli ortaggi. Portava una camicia a quadri con le maniche lunghe, chiaramente fuori stagione, come i pantaloni – forse di velluto un tempo? – che ormai mostravano solo un tessuto logoro. Ai piedi, dove il tallone poggiava, le scarpe erano state ripiegate assumendo la forma mansueta di ciabatta.
Di fronte alla domanda, con quella nota di percettibile insolenza, aveva deciso di rispondere con una sfumatura sarcastica, ma appena appena, in modo da lasciare uno spiraglio all’eventualità che lo scambio verbale potesse continuare su toni più concilianti.
– Quella roba là – e aveva calcato le parole – è la maggiorana, la pianta vicina è la santoreggia, l’altra…
Ma il vecchio non l’aveva lasciata finire. Con la mano libera aveva fatto un gesto stizzoso che sottolineava la frase che era seguita:
– Ah. Erba inutile, inutile fatica.
Quindi, lasciandola di stucco, aveva ripreso il cammino nella direzione del paese, con un’andatura sbilanciata per fare da contrappeso al cesto.
Era rimasta immobile: di personaggi strambi ne aveva visti, ma nessuno come lui, da quando era venuta ad abitare in quel luogo sperduto di sassi e dirupi. Lì, dove un cartello che ogni tanto pareva lusingarti con la speranza di una borgata, non manteneva le promesse: aspettative che finivano nel nulla, magari in stradine ghiaiose che si assottigliavano o che si estinguevano all’improvviso davanti ad una sbarra o ad un casolare in disfacimento.
Era ripassato una settimana dopo, mentre lei stava dando terra alle piante dei cardi. Ne aveva avvertito la presenza dall’ombra bislacca che il sole proiettava sul terreno, ma non si era voltata di proposito, chiedendosi se anche stavolta avrebbe proclamato qualcosa. Non l’aveva delusa.
– Quelle là si seccheranno prima che qualcuno le mangi.
Volutamente, neanche a sentenza sputata, aveva cambiato posizione. Aveva percepito il rumore dei passi che si allontanavano ed anche, chiaro, il commento conclusivo:
– Se si prova a fare i contadini, bisogna almeno sapere quando è il momento giusto per piantare.
Quel giorno, sentendosi in pace con il creato, aveva sorriso pensando che le piante di cardo assomigliavano al vecchiaccio: ruvide e scostanti, con la maturazione era prevedibile che le lamine diventassero ancora più pungenti, i filamenti più legnosi.
Certo, sarebbe stata una soddisfazione puntualizzare che lei non era nata per fare la contadina.
Ci stava solo provando da quando, arrivata alla fine dell’attività lavorativa, aveva voluto dare allo scorrere del tempo un modo nuovo, concreto, da vivere non assistendo passivamente al ritmo delle stagioni, ma anche nel parteciparvi.
Il suo sogno era un posto con un terreno di cui occuparsi, non importava se isolato dal mondo.
Nel tal caso aveva avuto una folgorazione notando il cartello “vendesi” sul muro di una vecchia casa, mentre girava alla ricerca per quei paesini sperduti. Un pezzo di terra intorno, da dissodare, spianare, coltivare. E lo sguardo dentro un orizzonte finito dove avrebbe potuto godere della soddisfazione quieta di mettere mano alle cose: era ciò che cercava.
Tornata con un tecnico, aveva visto che la casa poteva definirsi abitabile se con quest’aggettivo si voleva definire una vita senza pretese, e anche senza un riscaldamento centrale per dirla tutta.
Aveva passato i primi tempi lavorando sodo, mettendo mano alle stanzette, cercando di ammansire il terreno pietroso.
L’uomo sdrucito aveva preso l’abitudine di passare in modo abbastanza regolare.
A volte sentenziava puntando il dito verso un angolo dell’orto, altre invece si accontentava di muovere la testa in segno di disapprovazione: su che cosa? per cosa? Mah, saperlo. Meglio far finta di niente: non sarebbe stato lui a far traballare le fragili sicurezze di chi era ancora alla ricerca del senso delle scelte fatte.
L’idea che non passasse per caso si era fatta strada nella sua mente, altrimenti perché nei mesi precedenti non si era mai fatto vedere? Qualche volta aveva l’impressione che quelle zucchine, quei cespi d’insalata che ostentatamente spuntavano dal cesto non fossero stati messi lì per caso, ma in esposizione per lei, per farle vedere cosa ottiene chi è del mestiere. A dimostrazione che la terra sa ripagare solo chi si adopera sul serio.
Le giornate estive nel frattempo si susseguivano, con l’orto che sembrava averle concesso una tregua nella dura battaglia contro le gramigne. Dinnanzi ai riquadri ordinati, provava la sensazione che tutti pezzi sparsi che sentiva dentro di sé, ricordi e rimpianti, anche se a volte graffiavano ancora, stessero andando a posto. Aveva voluto lasciarsi alle spalle rapporti che l’asfissiavano, relazioni che l’avevano scavata dentro lasciandole solo l’involucro a custodire le sue fragilità. Era giunto il tempo di abbandonare la confusione, il baccano: il silenzio con cui stava imparando a fare amicizia non era un ripiego, ma un’indennità, un premio dovuto. Nell’appartenenza a quella terra, avvertiva il suo respiro liberarsi, come se fino ad allora avesse annaspato sott’acqua.
Intanto era giunto settembre, con l’oscurità che iniziava a scendere prima e che aveva qualcosa di amichevole. Nelle ore calde, cercando un ritaglio d’ombra al sole ancora vigoroso, le capitava a volte di puntare l’occhio sul sentiero per controllare se l’indecifrabile vecchio fosse di passaggio.
Un giorno di ottobre, mentre stava cercando di sistemare alcune latte di metallo arrugginito che una raffica di vento aveva portato a spasso, lui era passato e aveva dato il solito sguardo intorno, ma non aveva detto niente. Lei aveva voluto interpretare il suo silenzio come una concessione data a chi, in fondo, almeno mette la buona volontà in ciò che fa.
Novembre si era presentato con quell’umidore che la faceva indugiare di più in casa; un giorno, sentendo dei passi sul sentiero, aveva ripulito la condensa che il tempo nebbioso lasciava come una firma sui vetri. Era lui: stava immobile, sbilenco. Dopo aver sostato un po’, gli occhi acquosi a perlustrare le solitarie piante di verza rimaste, l’aveva visto frugare all’interno del cesto. Con le mani segnate da un tremito di cui non si era mai accorta prima, ne aveva estratto una rosa e l’aveva appoggiata sul muretto.
Allibita, si era precitata fuori ma lui, già ripreso il cammino, non si era nemmeno voltato mentre borbottava:
– Era rimasta l’unica in fondo all’orto, domani non l’avrei trovata più, la brina stanotte di sicuro l’avrebbe fatta morire.
Quasi presa da un senso di timore, si era avvicinata al muretto.
Era una rosa col gambo tutto spine robuste, tanto che non sapeva come afferrarla, senza pungersi.
Preziosa, inaspettata rosa di novembre.
Una di quelle rose solo abbozzate, dove il bocciolo intimorito non osa aprirsi al mondo, dai petali sgualciti, avvizziti vicino allo stelo.
Una rosa così, fragile e stropicciata, un po’ come lui.