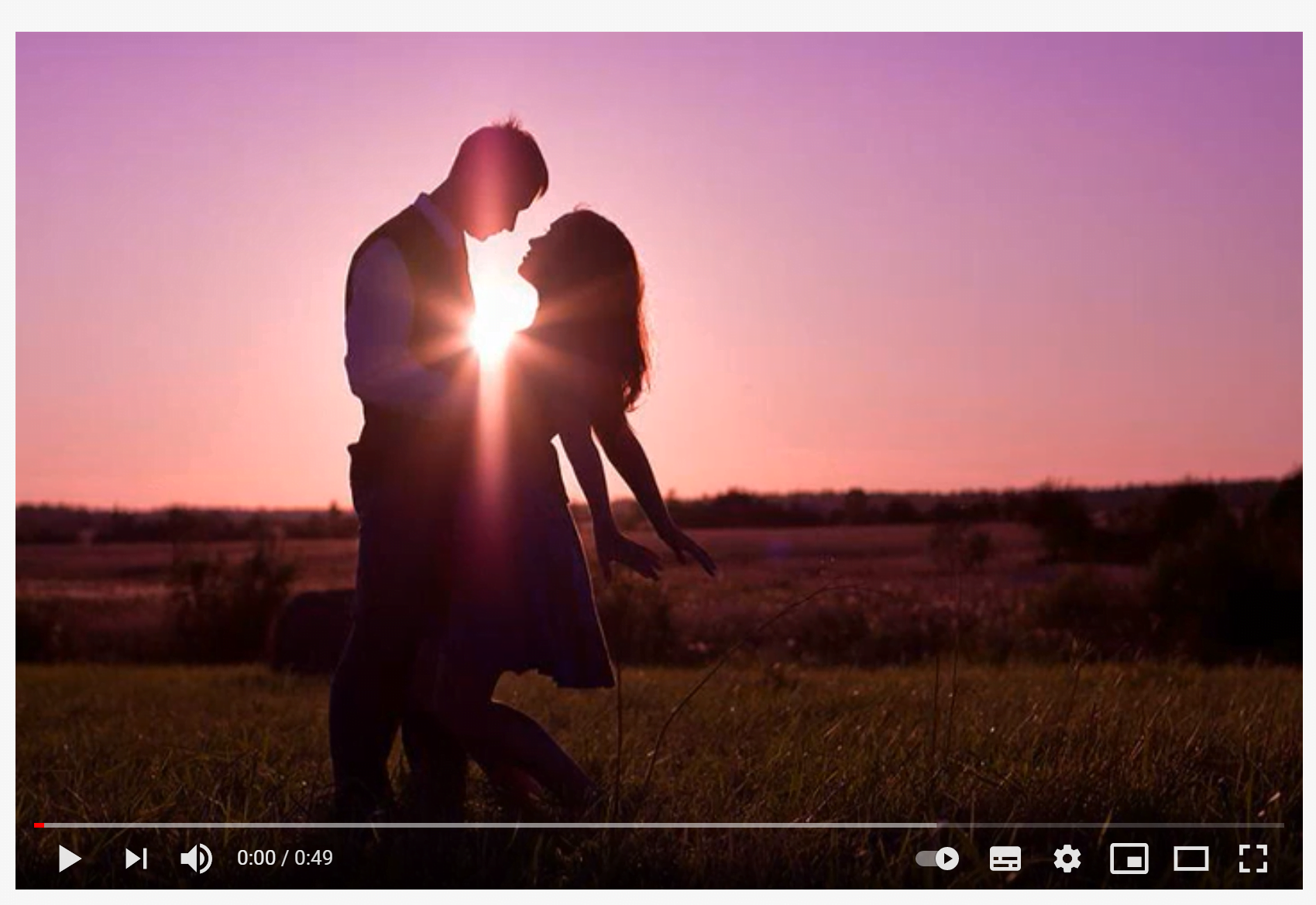Non hanno premuto l’interruttore fuori della porta prima di entrare nella camera buia: la luce impietosa avrebbe potuto togliere in un sol colpo quello stato di anestesia con cui hanno tentato di foderare le emozioni prima di mettere piede nella stanza.
Chiudere fuori i pensieri e, se cercano di farsi strada, che non vaghino, sbaragliarli, fermarli a tutti i costi: eseguire il compito, visto che è da fare, metter mano fra quegli oggetti, smistare o buttare, come se appartenessero ad un’estranea.
Alzano con lentezza la tapparella, lasciando che la luce entri con gradualità, il più rispettosa possibile, sveli strato dopo strato, orizzontalmente, le forme note dei mobili.
L’armadio: meglio iniziare da lassù, in alto, con la scatola della vestaglia comprata, spiegata e ripiegata per un domani che non c’è mai stato, orpello sfizioso, inutile accessorio nella casa di riposo. Di fianco le camicie da notte, anch’esse mai usate, troppo lunghe e troppo larghe, dai colori pastello, concessione cromatica straordinaria per un’età in cui il suo abbigliamento prevedeva più che altro capi scuri. Quando si era liberato il posto per lei al ricovero, nella lista c’era scritto “pigiami”, poi però per velocizzare il cambio di notte le infilavano solo la maglietta. Le figlie adesso rigirano fra le mani quelle camicie che almeno le avrebbero coperto le gambe magre, dalla pelle sottilissima, due stecchi anchilosati, infreddoliti d’inverno e d’estate.
Le figlie adesso rigirano fra le mani quelle camicie che almeno le avrebbero coperto le gambe magre, dalla pelle sottilissima, due stecchi anchilosati, infreddoliti d’inverno e d’estate.
Più in basso le maglie, indossate nell’ultimo inverno in cui la madre era ancora qui nella casa perché, anche se tendevano ad infeltrire, assolvevano il loro compito: tenevano caldi busto e braccia. Le mani no, non c’era modo di scaldarle, come se il sangue avesse deciso di terminare prima il suo giro ora che quelle appendici, che tanto daffare si erano date, non si occupavano più di niente, niente producevano.
In basso le gonne, ben allineate, appese ai loro appendini; le mani lisciano quelle a pieghe. – Come mi piacciono le gonne a pieghe – diceva. Anche queste sono rimaste qui, non erano adatte per l’ultimo soggiorno: lì dentro nessuno avrebbe avuto tempo per ripassare con il ferro da stiro, una ad una, quelle piegoline.
Ora tocca alle lenzuola ricamate, di cotone grosso, che hanno sfidato il tempo. Chissà se aveva pensato che sarebbero passate in altri cassetti? No, le figlie che accarezzano i rilievi su cui l’ago aveva indugiato, ore ed ore, non vogliono quelle lenzuola associate al suo gran male di vivere, alle angosce, al terrore quando lì si sentiva prigioniera, affrontava il corridoio, picchiava la porta di casa.
– E’ notte, è buio – inutili le rassicurazioni: la notte e il buio che aveva dentro erano più forti e allora scalciava: via quelle lenzuola che aveva cucito e ricamato. Prima della malattia raccontava spesso che
aveva un grande rimpianto: sua madre non le aveva permesso di andare da una sarta ad imparare a tagliare le stoffe. Quindi si doveva far aiutare per abbozzare quello che cuciva, ma poi sfornava vestiti e pigiamini per le nipoti; con i rimasugli di tessuto, avanti con tovagliette, presine, strofinacci da cucina per tutti, da regalare, preparando il filo nella cruna dell’ago la sera per la mattina successiva perché le mani deformate dall’artrosi non obbedivano pronte al risveglio, quando non vedeva l’ora di rimettersi al lavoro.
Altri cassetti, nuove ante da spalancare alla luce e ai ricordi mentre il distacco imposto, già incrinato con la visione delle vestaglie ed ora inesorabilmente abbandonato, è aggredito dagli oggetti.
Strana cosa gli oggetti.
Così inanimati, così carichi.
Anche se inconsistenti, pesanti come pietre.
Beffardi nello scuotere lo stato di indifferenza con cui ci si illude di manipolarli.
Prepotenti nel trascinare con sé immagini.
Spietati nello smuovere rimpianti.
Cerate, bavaglie: oggetti che riconducono ad un corpo che non era in grado di badare a se stesso. I pensieri non più trattenuti, allo sbaraglio: quello del bagno la prima volta in cui avevano capito che aveva bisogno di aiuto per lavarsi. Lei, che già non si districava fra mattina o pomeriggio, di fronte a quest’intromissione forzata, anche se le figlie avevano cercato di entrare nella sua intimità sforzandosi di trovare parole che non le facessero del male, si era messa a piangere: – Come mi sono ridotta.
Con l’andar del tempo avevano tralasciato quelle delicatezze. Dentro la vasca bisognava tenere a forza quel corpo che il tempo e la malattia avevano complottato per saccheggiare. Un corpo svuotato che non collaborava e come un oggetto trattato, spesso una lotta che lasciava tutte sfinite.
Altro cassetto. Le bollette, sistemate una ad una, con le annotazioni sulla busta finché aveva potuto, cercando di affidare alla scrittura, sempre più grande e tremolante con il passare del tempo, ciò che faticava a ricordare
Una busta grande, i referti di visite e radiografie per quelle mani nodose, contorte, con l’artrosi iniziata forse quando, ancora giovane, andava al fiume a lavare, peggiorata con i lavori pesanti cui non si era mai tirata indietro.
In un bustone il responso dei controlli che si erano succeduti negli anni dal geriatra che, alle varie voci sull’autonomia, accumulavano sempre più punti, una gara in retrocessione. La prima volta era stata la più dura. Lei annaspava nella confusione per quei vuoti di memoria. Le figlie sapevano che non ci sarebbe stata cura efficace per fermare quel brancolare nel tempo e nello spazio, lo sguardo che si perdeva in un mare di liquidità. Ma, per convincerla, le avevano prospettato la prescrizione di una pastiglietta miracolosa che avrebbe riportato tutto come prima, illudendola che avrebbe riacquistato la sua autonomia, bramata più di tutto.
– La cosa più importante per una persona – asseriva gli anni precedenti – è non perdere l’uso della testa.
Il cassetto delle carte della pensione, in un foglio una sotto l’altra, mese dopo mese, la scritta di quella cifra che andava a prendersi all’ufficio postale, quei numeri su cui le figlie e i nipoti scherzavano. – Bisogna imparare dalla nonna: con tre soldi sa pure risparmiare.
Ed ancora scatoline con medagliette che qualcuno andato a qualche santuario aveva portato come ricordo a lei che non aveva mai lasciato il suo paese; ecco i rosari che aveva l’abitudine di sgranare la sera, quando andava a letto, sempre molto presto, secondo un’abitudine presa in gioventù perché il lavoro dei campi l’aspettava già prima dell’alba.
In un angolino, legate con un nastro vezzoso, le cartoline che il futuro marito spediva dall’estero o dalla grande città dove era arrivato per mettere da parte qualcosa che permettesse un futuro, per lui e per lei. Poi, una sera di giugno quei sogni si erano interrotti di colpo: era partito per l’ultimo viaggio, stavolta senza valigia e l’aveva lasciata sola, vedova in un’età in cui credeva di avere ancora tanti anni davanti da dividere con lui.
grande città dove era arrivato per mettere da parte qualcosa che permettesse un futuro, per lui e per lei. Poi, una sera di giugno quei sogni si erano interrotti di colpo: era partito per l’ultimo viaggio, stavolta senza valigia e l’aveva lasciata sola, vedova in un’età in cui credeva di avere ancora tanti anni davanti da dividere con lui.
Le figlie lasciano lì le promesse di una vita, fermate da un pudore che non avrebbe più motivo di esistere. Magari un’altra volta slacceranno il nastro, passeranno in rassegna quelle cartoline, leggeranno le parole. Ora no.
Ora hanno solo fretta di richiudere tutto, anche se altre stanze aspettano di essere rovistate, altre immagini implacabilmente rivangate, l’apparente innocuo pronto a ferire. Riabbassare le tapparelle, riportare il buio, dopo aver spostato i sacchi, ormai pesanti, chiuderli e così allontanare dagli occhi e, se possibile, dall’anima, la visione di ogni oggetto.
Domani, le altre stanze domani, rituffandosi dentro cassetti, svuotando ante, spostando oggetti che non dovrebbero parlare, invece gridano.
Loretta Casagrande
[bs-white-space]