Una piccola raccolta delle poesie di Leopardi. Non sono proprio tutte, ma sicuramente troverai le più belle scritte dall’autore.

Giacomo Leopardi è considerato una delle più importanti figure della letteratura mondiale. Sicuramente il maggior poeta italiano dell’Ottocento.
La sua poesia si concentra sull’esistenza e sulla condizione umana, tanto che può considerarsi pure un filoso di spessore.
Inizialmente sostenitore del classicismo, si sposta poi verso il romanticismo, divenendone uno dei maggiori esponenti in ambito letterario. Le poesie di Giacomo Leopardi che troverai di seguito quasi tutte appartenenti alla seconda fase della sua arte.
Le poesie più belle di Giacomo Leopardi
Tra le poesie di Leopardi come non annoverare: A Silvia, L’infinito, A te stesso, A un vincitore nel pallone, All’Italia, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, Consalvo, Il Sabato del villaggio, La ginestra, La quieta dopo la tempesta, La sera del dì di festa, Ultimo canto di Saffo, XVIII – Alla sua donna, Il Passero solitario.
L’infinito
Scritta a Recanati tra il 1818 e il 1819: il tema di questa poesie caratterizza la sua prima fase, la poetica del vago e dell’indefinito. È uno delle più famose poesie di Leopardi, nonché uno dei primi componimenti. Puoi leggere un breve commento e ascoltare la lettura de L’infinito sempre sul nostro sito.
Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
E questa siepe, che da tanta parte
Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
Spazi di là da quella, e sovrumani
Silenzi, e profondissima quiete
Io nel pensier mi fingo; ove per poco
Il cor non si spaura. E come il vento
Odo stormir tra queste piante, io quello
Infinito silenzio a questa voce
Vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
E le morte stagioni, e la presente
E viva, e il suon di lei. Così tra questa
Immensità s’annega il pensier mio:
E il naufragar m’è dolce in questo mare.
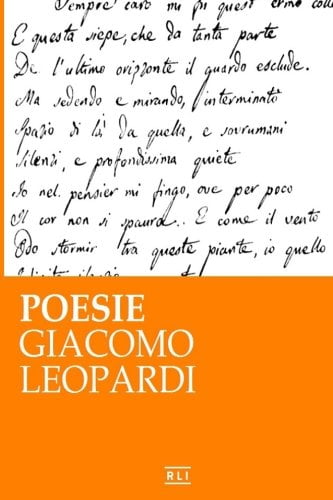
A Silvia
Scritta nel 1828: “A Silvia” è una delle poesie più famose del poeta romantico e introduce il tema del pessimismo cosmico. Leopardi vede la natura come matrigna, causa primaria della sofferenza dell’essere umano.
Silvia, rimembri ancora
quel tempo della tua vita mortale,
quando beltá splendea
negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,
e tu, lieta e pensosa, il limitare
di gioventú salivi?Sonavan le quiete
stanze, e le vie dintorno,
al tuo perpetuo canto,
allor che all’opre femminili intenta
sedevi, assai contenta
di quel vago avvenir che in mente avevi.
Era il maggio odoroso: e tu solevi
cosí menare il giorno.Io, gli studi leggiadri
talor lasciando e le sudate carte,
ove il tempo mio primo
e di me si spendea la miglior parte,
d’in su i veroni del paterno ostello
porgea gli orecchi al suon della tua voce,
ed alla man veloce
che percorrea la faticosa tela.
Mirava il ciel sereno,
le vie dorate e gli orti,
e quinci il mar da lungi, e quindi il monte.
Lingua mortal non dice
quel ch’io sentiva in seno.Che pensieri soavi,
che speranze, che cori, o Silvia mia!
Quale allor ci apparia
la vita umana e il fato!
Quando sovviemmi di cotanta speme,
un affetto mi preme
acerbo e sconsolato,
e tornami a doler di mia sventura.
O natura, o natura,
perché non rendi poi
quel che prometti allor? perché di tanto
inganni i figli tuoi?Tu, pria che l’erbe inaridisse il verno,
da chiuso morbo combattuta e vinta,
perivi, o tenerella. E non vedevi
il fior degli anni tuoi;
non ti molceva il core
la dolce lode or delle negre chiome,
or degli sguardi innamorati e schivi;
né teco le compagne ai dí festivi
ragionavan d’amore.Anche pería fra poco
la speranza mia dolce: agli anni miei
anche negâro i fati
la giovanezza. Ahi, come,
come passata sei,
cara compagna dell’etá mia nova,
mia lacrimata speme!
questo è quel mondo? questi
i diletti, l’amor, l’opre, gli eventi,
onde cotanto ragionammo insieme?
questa la sorte dell’umane genti?
All’apparir del vero
tu, misera, cadesti: e con la mano
la fredda morte ed una tomba ignuda
mostravi di lontano.
La quiete dopo la tempesta
Scritta nel 1829 ma pubblicata per la prima volta nel 1831. Possiamo dividere la poesia in due parti. Nella prima il tema sembra lontano dal pessimismo cosmico. Ma nella seconda parte l’autore parla della causa e dell’inesorabilità della sofferenza umana. Si può provare gioia solamente nella momentanea cessazione del dolore, che è invece una componente assai più abbondante nella vita di un individuo. Per Leopardi la felicità non esiste, sono effimeri momenti di non dolore.
Passata è la tempesta:
odo augelli far festa, e la gallina,
tornata in su la via,
che ripete il suo verso. Ecco il sereno
rompe lá da ponente, alla montagna:
sgombrasi la campagna,
e chiaro nella valle il fiume appare.
Ogni cor si rallegra, in ogni lato
risorge il romorio,
torna il lavoro usato.
L’artigiano a mirar l’umido cielo,
con l’opra in man, cantando,
fassi in su l’uscio; a prova
vien fuor la femminetta a côr dell’acqua
della novella piova;
e l’erbaiuol rinnova
di sentiero in sentiero
il grido giornaliero.
Ecco il sol che ritorna, ecco sorride
per li poggi e le ville. Apre i balconi,
apre terrazzi e logge la famiglia:
e, dalla via corrente, odi lontano
tintinnio di sonagli; il carro stride
del passeggier che il suo cammin ripiglia.Si rallegra ogni core.
Sí dolce, sí gradita
quand’è, com’or, la vita?
Quando con tanto amore
l’uomo a’ suoi studi intende?
o torna all’opre? o cosa nova imprende?
quando de’ mali suoi men si ricorda?
Piacer figlio d’affanno;
gioia vana, ch’è frutto
del passato timore, onde si scosse
e paventò la morte
chi la vita abborria;
onde in lungo tormento,
fredde, tacite, smorte,
sudâr le genti e palpitâr, vedendo
mossi alle nostre offese
folgori, nembi e vento.O natura cortese,
son questi i doni tuoi,
questi i diletti sono
che tu porgi ai mortali. Uscir di pena
è diletto fra noi.
Pene tu spargi a larga mano; il duolo
spontaneo sorge e di piacer, quel tanto
che per mostro e miracolo talvolta
nasce d’affanno, è gran guadagno. Umana
prole cara agli eterni! assai felice
se respirar ti lice
d’alcun dolor; beata
se te d’ogni dolor morte risana.
Il sabato del villaggio
Composta nel 1829. Rientra senza dubbio tra le poesie di Leopardi più conosciute e più belle.
La donzelletta vien dalla campagna,
in sul calar del sole,
col suo fascio dell’erba, e reca in mano
un mazzolin di rose e di viole,
onde, siccome suole,
ornare ella si appresta
dimani, al dí di festa, il petto e il crine.
Siede con le vicine
su la scala a filar la vecchierella,
incontro lá dove si perde il giorno;
e novellando vien del suo buon tempo,
quando ai dí della festa ella si ornava,
ed ancor sana e snella
solea danzar la sera intra di quei
ch’ebbe compagni dell’etá piú bella.
Giá tutta l’aria imbruna,
torna azzurro il sereno, e tornan l’ombre
giú da’ colli e da’ tetti,
al biancheggiar della recente luna.
Or la squilla dá segno
della festa che viene;
ed a quel suon diresti
che il cor si riconforta.
I fanciulli gridando
su la piazzuola in frotta,
e qua e lá saltando,
fanno un lieto romore:
e intanto riede alla sua parca mensa,
fischiando, il zappatore,
e seco pensa al dí del suo riposo.Poi quando intorno è spenta ogni altra face,
e tutto l’altro tace,
odi il martel picchiare, odi la sega
del legnaiuol, che veglia
nella chiusa bottega alla lucerna,
e s’affretta, e s’adopra
di fornir l’opra anzi il chiarir dell’alba.Questo di sette è il piú gradito giorno,
pien di speme e di gioia:
diman tristezza e noia
recheran l’ore, ed al travaglio usato
ciascuno in suo pensier fará ritorno.Garzoncello scherzoso,
cotesta etá fiorita
è come un giorno d’allegrezza pieno,
giorno chiaro, sereno,
che precorre alla festa di tua vita.
Godi, fanciullo mio; stato soave,
stagion lieta è cotesta.
Altro dirti non vo’; ma la tua festa
ch’anco tardi a venir non ti sia grave.
Il passero solitario
Leopardi in questa poesia nota che diverse caratteristiche lo accomunano a un uccellino: entrambi sono soli e sembrano destinati a rimanerlo. Una profonda riflessione sulla solitudine.
D’in su la vetta della torre antica,
passero solitario, alla campagna
cantando vai finché non more il giorno;
ed erra l’armonia per questa valle.
Primavera d’intorno
brilla nell’aria, e per li campi esulta,
sí ch’a mirarla intenerisce il core.
Odi greggi belar, muggire armenti;
gli altri augelli contenti, a gara insieme
per lo libero ciel fan mille giri,
pur festeggiando il lor tempo migliore:
tu pensoso in disparte il tutto miri;
non compagni, non voli,
non ti cal d’allegria, schivi gli spassi;
canti, e cosí trapassi
dell’anno e di tua vita il piú bel fiore.Oimè, quanto somiglia
al tuo costume il mio! Sollazzo e riso,
della novella etá dolce famiglia,
e te, german di giovinezza, amore,
sospiro acerbo de’ provetti giorni,
non curo, io non so come; anzi da loro
quasi fuggo lontano;
quasi romito, e strano
al mio loco natio,
passo del viver mio la primavera.
Questo giorno, ch’omai cede alla sera,
festeggiar si costuma al nostro borgo.
Odi per lo sereno un suon di squilla,
odi spesso un tonar di ferree canne,
che rimbomba lontan di villa in villa.
Tutta vestita a festa
la gioventú del loco
lascia le case, e per le vie si spande;
e mira ed è mirata, e in cor s’allegra.
Io, solitario in questa
rimota parte alla campagna uscendo,
ogni diletto e gioco
indugio in altro tempo; e intanto il guardo
steso nell’aria aprica
mi fère il sol, che tra lontani monti,
dopo il giorno sereno,
cadendo si dilegua, e par che dica
che la beata gioventú vien meno.Tu, solingo augellin, venuto a sera
del viver che daranno a te le stelle,
certo del tuo costume
non ti dorrai; ché di natura è frutto
ogni vostra vaghezza.
A me, se di vecchiezza
la detestata soglia
evitar non impetro,
quando muti questi occhi all’altrui core,
e lor fia vòto il mondo, e il dí futuro
del dí presente piú noioso e tetro,
che parrá di tal voglia?
che di quest’anni miei? che di me stesso?
Ahi! pentirommi, e spesso,
ma sconsolato, volgerommi indietro.
Alla luna
Scritta nel 1820, ha come tema principale quello del ricordo. Non è l’unica tra le poesie di Leopardi ad avere questo tema, continua a leggere le altre.
O graziosa Luna, io mi rammento
che, or volge l’anno, sovra questo colle
io venia pien d’angoscia a rimirarti:
e tu pendevi allor su quella selva,
siccome or fai, che tutta la rischiari.
Ma nebuloso e tremulo dal pianto,
che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci
il tuo volto apparia, ché travagliosa
era mia vita: ed è, né cangia stile,
o mia diletta Luna. E pur mi giova
la ricordanza, e il noverar l’etate
del mio dolore. Oh come grato occorre
nel tempo giovanil, quando ancor lungo
la speme e breve ha la memoria il corso,
il rimembrar delle passate cose,
ancor che triste, e che l’affanno duri!
La sera del dì di festa
Anche questa poesia è del 1820. Personifica l’infelicità della sua esistenza, come una donna lontana e indifferente, irraggiungibile.
Dolce e chiara è la notte e senza vento,
e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti
posa la luna, e di lontan rivela
serena ogni montagna. O donna mia,
giá tace ogni sentiero, e pei balconi
rara traluce la notturna lampa:
tu dormi, ché t’accolse agevol sonno
nelle tue chete stanze; e non ti morde
cura nessuna; e giá non sai né pensi
quanta piaga m’apristi in mezzo al petto.
Tu dormi: io questo ciel, che sí benigno
appare in vista, a salutar m’affaccio,
e l’antica natura onnipossente,
che mi fece all’affanno. — A te la speme
nego — mi disse, — anche la speme; e d’altro
non brillin gli occhi tuoi se non di pianto. —
Questo dí fu solenne: or da’ trastulli
prendi riposo; e forse ti rimembra
in sogno a quanti oggi piacesti, e quanti
piacquero a te: non io, non giá ch’io speri,
al pensier ti ricorro. Intanto io chieggo
quanto a viver mi resti, e qui per terra
mi getto, e grido, e fremo. O giorni orrendi
in cosí verde etate! Ahi! per la via
odo non lunge il solitario canto
dell’artigian, che riede a tarda notte,
dopo i sollazzi, al suo povero ostello;
e fieramente mi si stringe il core,
a pensar come tutto al mondo passa,
e quasi orma non lascia. Ecco è fuggito
il dí festivo, ed al festivo il giorno
volgar succede, e se ne porta il tempo
ogni umano accidente. Or dov’è il suono
di que’ popoli antichi? or dov’è il grido
de’ nostri avi famosi, e il grande impero
di quella Roma, e l’armi, e il fragorío
che n’andò per la terra e l’oceáno?
Tutto è pace e silenzio, e tutto posa
il mondo, e piú di lor non si ragiona.
Nella mia prima etá, quando s’aspetta
bramosamente il dí festivo, or poscia
ch’egli era spento, io doloroso, in veglia,
premea le piume; ed alla tarda notte
un canto, che s’udía per li sentieri
lontanando morire a poco a poco,
giá similmente mi stringeva il core..
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
È la poesia che incarna in tutto e per tutto il Romanticismo.
Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,
silenziosa luna?
Sorgi la sera, e vai,
contemplando i deserti; indi ti posi.
Ancor non sei tu paga
di riandare i sempiterni calli?
Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga
di mirar queste valli?
Somiglia alla tua vita
la vita del pastore.
Sorge in sul primo albore
move la greggia oltre pel campo, e vede
greggi, fontane ed erbe;
poi stanco si riposa in su la sera:
altro mai non ispera.
Dimmi, o luna: a che vale
al pastor la sua vita,
la vostra vita a voi? dimmi: ove tende
questo vagar mio breve,
il tuo corso immortale?Vecchierel bianco, infermo,
mezzo vestito e scalzo,
con gravissimo fascio in su le spalle,
per montagna e per valle,
per sassi acuti, ed alta rena, e fratte,
al vento, alla tempesta, e quando avvampa
l’ora, e quando poi gela,
corre via, corre, anela,
varca torrenti e stagni,
cade, risorge, e piú e piú s’affretta,
senza posa o ristoro,
lacero, sanguinoso; infin ch’arriva
colá dove la via
e dove il tanto affaticar fu vòlto:
abisso orrido, immenso,
ov’ei precipitando, il tutto obblia.
Vergine luna, tale
è la vita mortale.Nasce l’uomo a fatica,
ed è rischio di morte il nascimento.
Prova pena e tormento
per prima cosa; e in sul principio stesso
la madre e il genitore
il prende a consolar dell’esser nato.
Poi che crescendo viene,
l’uno e l’altro il sostiene, e via pur sempre
con atti e con parole
studiasi fargli core,
e consolarlo dell’umano stato:
altro ufficio piú grato
non si fa da parenti alla lor prole.
Ma perché dare al sole,
perché reggere in vita
chi poi di quella consolar convenga?
Se la vita è sventura,
perché da noi si dura?
Intatta luna, tale
è lo stato mortale.
Ma tu mortal non sei,
e forse del mio dir poco ti cale.Pur tu, solinga, eterna peregrina,
che sí pensosa sei, tu forse intendi
questo viver terreno,
il patir nostro, il sospirar, che sia;
che sia questo morir, questo supremo
scolorar del sembiante,
e perir della terra, e venir meno
ad ogni usata, amante compagnia.
E tu certo comprendi
il perché delle cose, e vedi il frutto
del mattin, della sera,
del tacito, infinito andar del tempo.
Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore
rida la primavera,
a chi giovi l’ardore, e che procacci
il verno co’ suoi ghiacci.
Mille cose sai tu, mille discopri,
che son celate al semplice pastore.
Spesso quand’io ti miro
star cosí muta in sul deserto piano,
che, in suo giro lontano, al ciel confina;
ovver con la mia greggia
seguirmi viaggiando a mano a mano;
e quando miro in cielo arder le stelle;
dico fra me pensando:
— A che tante facelle?
che fa l’aria infinita, e quel profondo
infinito seren? che vuol dir questa
solitudine immensa? ed io che sono? —
Cosí meco ragiono: e della stanza
smisurata e superba,
e dell’innumerabile famiglia;
poi di tanto adoprar, di tanti moti
d’ogni celeste, ogni terrena cosa,
girando senza posa,
per tornar sempre lá donde son mosse;
uso alcuno, alcun frutto
indovinar non so. Ma tu per certo,
giovinetta immortal, conosci il tutto.
Questo io conosco e sento,
che degli eterni giri,
che dell’esser mio frale,
qualche bene o contento
avrá fors’altri; a me la vita è male.O greggia mia che posi, oh te beata,
che la miseria tua, credo, non sai!
Quanta invidia ti porto!
Non sol perché d’affanno
quasi libera vai;
ch’ogni stento, ogni danno,
ogni estremo timor subito scordi;
ma piú perché giammai tedio non provi.
Quando tu siedi all’ombra, sovra l’erbe,
tu se’ queta e contenta;
e gran parte dell’anno
senza noia consumi in quello stato.
Ed io pur seggo sovra l’erbe, all’ombra,
e un fastidio m’ingombra
la mente; ed uno spron quasi mi punge
sí che, sedendo, piú che mai son lunge
da trovar pace o loco.
E pur nulla non bramo,
e non ho fino a qui cagion di pianto.
Quel che tu goda o quanto,
non so giá dir; ma fortunata sei.
Ed io godo ancor poco,
o greggia mia, né di ciò sol mi lagno.
Se tu parlar sapessi, io chiederei:
— Dimmi: perché giacendo
a bell’agio, ozioso,
s’appaga ogni animale;
me, s’io giaccio in riposo, il tedio assale?Forse s’avess’io l’ale
da volar su le nubi,
e noverar le stelle ad una ad una,
o come il tuono errar di giogo in giogo,
piú felice sarei, dolce mia greggia,
piú felice sarei, candida luna.
O forse erra dal vero,
mirando all’altrui sorte, il mio pensiero:
forse in qual forma, in quale
stato che sia, dentro covile o cuna,
è funesto a chi nasce il dí natale.
Le ricordanze
Torna il tema del ricordo in questa meravigliosa poesia di Leopardi.
Vaghe stelle dell’Orsa, io non credea
tornare ancor per uso a contemplarvi
sul paterno giardino scintillanti,
e ragionar con voi dalle finestre
di questo albergo ove abitai fanciullo,
e delle gioie mie vidi la fine.
Quante immagini un tempo, e quante fole
creommi nel pensier l’aspetto vostro
e delle luci a voi compagne! allora
che, tacito, seduto in verde zolla,
delle sere io solea passar gran parte
mirando il cielo, ed ascoltando il canto
della rana rimota alla campagna!
E la lucciola errava appo le siepi
e in su l’aiuole, susurrando al vento
i viali odorati, ed i cipressi
lá nella selva; e sotto al patrio tetto
sonavan voci alterne, e le tranquille
opre de’ servi. E che pensieri immensi,
che dolci sogni mi spirò la vista
di quel lontano mar, quei monti azzurri,
che di qua scopro, e che varcare un giorno
io mi pensava, arcani mondi, arcana
felicitá fingendo al viver mio!
ignaro del mio fato, e quante volte
questa mia vita dolorosa e nuda
volentier con la morte avrei cangiato.Né mi diceva il cor che l’etá verde
sarei dannato a consumare in questo
natio borgo selvaggio, intra una gente
zotica, vil, cui nomi strani, e spesso
argomento di riso e di trastullo
son dottrina e saper; che m’odia e fugge,
per invidia non giá, ché non mi tiene
maggior di sé, ma perché tale estima
ch’io mi tenga in cor mio, sebben di fuori
a persona giammai non ne fo segno.
Qui passo gli anni, abbandonato, occulto,
senz’amor, senza vita; ed aspro a forza
tra lo stuol de’ malevoli divengo:
qui di pietá mi spoglio e di virtudi,
e sprezzator degli uomini mi rendo,
per la greggia c’ho appresso: e intanto vola
il caro tempo giovanil, piú caro
che la fama e l’allòr, piú che la pura
luce del giorno, e lo spirar: ti perdo
senza un diletto, inutilmente, in questo
soggiorno disumano, intra gli affanni,
o dell’arida vita unico fiore.Viene il vento recando il suon dell’ora
dalla torre del borgo. Era conforto
questo suon, mi rimembra, alle mie notti,
quando fanciullo, nella buia stanza,
per assidui terrori io vigilava,
sospirando il mattin. Qui non è cosa
ch’io vegga o senta, onde un’immagin dentro
non torni, e un dolce rimembrar non sorga;
dolce per sé; ma con dolor sottentra
il pensier del presente, un van desio
del passato, ancor tristo, e il dire: — Io fui. —
Quella loggia colá, vòlta agli estremi
raggi del dí; queste dipinte mura,
quei figurati armenti, e il sol che nasce
su romita campagna, agli ozi miei
porser mille diletti allor che al fianco
m’era, parlando, il mio possente errore
sempre, ov’io fossi. In queste sale antiche,
al chiaror delle nevi, intorno a queste
ampie finestre sibilando il vento,
rimbombâro i sollazzi e le festose
mie voci al tempo che l’acerbo, indegno
mistero delle cose a noi si mostra
pien di dolcezza; indelibata, intera
il garzoncel, come inesperto amante,
la sua vita ingannevole vagheggia,
e celeste beltá fingendo ammira.O speranze, speranze; ameni inganni
della mia prima etá! sempre, parlando,
ritorno a voi; ché, per andar di tempo,
per variar d’affetti e di pensieri,
obbliarvi non so. Fantasmi, intendo,
son la gloria e l’onor; diletti e beni
mero desio; non ha la vita un frutto,
inutile miseria. E sebben vòti
son gli anni miei, sebben deserto, oscuro
il mio stato mortal, poco mi toglie
la fortuna, ben veggo. Ahi! ma qualvolta
a voi ripenso, o mie speranze antiche,
ed a quel caro immaginar mio primo;
indi riguardo il viver mio sí vile
e sí dolente, e che la morte è quello
che di cotanta speme oggi m’avanza;
sento serrarmi il cor, sento ch’al tutto
consolarmi non so del mio destino.
E quando pur questa invocata morte
sarammi allato, e sará giunto il fine
della sventura mia; quando la terra
mi fia straniera valle, e dal mio sguardo
fuggirá l’avvenir; di voi per certo
risovverrammi; e quell’imago ancora
sospirar mi fará, farammi acerbo
l’esser vissuto indarno, e la dolcezza
del dí fatal tempererá d’affanno.E giá nel primo giovanil tumulto
di contenti, d’angosce e di desio,
morte chiamai piú volte, e lungamente
mi sedetti colá su la fontana
pensoso di cessar dentro quell’acque
la speme e il dolor mio. Poscia, per cieco
malor, condotto della vita in forse,
piansi la bella giovanezza, e il fiore
de’ miei poveri dí, che sí per tempo
cadeva: e spesso all’ore tarde, assiso
sul conscio letto, dolorosamente
alla fioca lucerna poetando,
lamentai co’ silenzi e con la notte
il fuggitivo spirto, ed a me stesso
in sul languir cantai funereo canto.Chi rimembrar vi può senza sospiri,
o primo entrar di giovinezza, o giorni
vezzosi, inenarrabili, allor quando
al rapito mortal primieramente
sorridon le donzelle; a gara intorno
ogni cosa sorride; invidia tace,
non desta ancora ovver benigna; e quasi
(inusitata maraviglia!) il mondo
la destra soccorrevole gli porge,
scusa gli errori suoi, festeggia il novo
suo venir nella vita, ed inchinando
mostra che per signor l’accolga e chiami?
Fugaci giorni! a somigliar d’un lampo
son dileguati. E qual mortale ignaro
di sventura esser può, se a lui giá scorsa
quella vaga stagion, se il suo buon tempo,
se giovanezza, ahi giovanezza! è spenta?O Nerina! e di te forse non odo
questi luoghi parlar? caduta forse
dal mio pensier sei tu? Dove sei gita,
che qui sola di te la ricordanza
trovo, dolcezza mia? Piú non ti vede
questa terra natal: quella finestra,
ond’eri usata favellarmi, ed onde
mesto riluce delle stelle il raggio,
è deserta. Ove sei, che piú non odo
la tua voce sonar, siccome un giorno,
quando soleva ogni lontano accento
del labbro tuo, ch’a me giungesse, il volto
scolorarmi? Altro tempo. I giorni tuoi
fûro, mio dolce amor. Passasti. Ad altri
il passar per la terra oggi è sortito,
e l’abitar questi odorati colli.
Ma rapida passasti, e come un sogno
fu la tua vita. Ivi danzando, in fronte
la gioia ti splendea, splendea negli occhi
quel confidente immaginar, quel lume
di gioventú, quando spegneali il fato,
e giacevi. Ahi Nerina! In cor mi regna
l’antico amor. Se a feste anco talvolta,
se a radunanze io movo, infra me stesso
dico: — O Nerina, a radunanze, a feste
tu non ti acconci piú, tu piú non movi. —
Se torna maggio, e ramoscelli e suoni
van gli amanti recando alle fanciulle,
dico: — Nerina mia, per te non torna
primavera giammai, non torna amore. —
Ogni giorno sereno, ogni fiorita
piaggia ch’io miro, ogni goder ch’io sento,
dico: — Nerina or piú non gode; i campi,
l’aria non mira. — Ahi! tu passasti, eterno
sospiro mio: passasti; e fia compagna
d’ogni mio vago immaginar, di tutti
i miei teneri sensi, i tristi e cari
moti del cor, la rimembranza acerba.
A se stesso
Forse un po’ insolita tra le poesie di Leopardi. Lo pensi anche tu?
Or poserai per sempre,
stanco mio cor. Perí l’inganno estremo,
ch’eterno io mi credei. Perí. Ben sento,
in noi di cari inganni,
non che la speme, il desiderio è spento.
Posa per sempre. Assai
palpitasti. Non val cosa nessuna
i moti tuoi, né di sospiri è degna
la terra. Amaro e noia
la vita, altro mai nulla; e fango è il mondo.
T’acqueta omai. Dispera
l’ultima volta. Al gener nostro il fato
non donò che il morire. Omai disprezza
te, la natura, il brutto
poter che, ascoso, a comun danno impera,
e l’infinita vanitá del tutto.
La ginestra, o fiore del deserto
Una tra le più significative delle poesie di Giacomo Leopardi.
Qui su l’arida schiena
Del formidabil monte
Sterminator Vesevo,
La qual null’altro allegra arbor nè fiore,
Tuoi cespi solitari intorno spargi,
Odorata ginestra,
Contenta dei deserti. Anco ti vidi
De’ tuoi steli abbellir l’erme contrade
Che cingon la cittade
La qual fu donna de’ mortali un tempo,
E del perduto impero
Par che col grave e taciturno aspetto
Faccian fede e ricordo al passeggero.
Or ti riveggo in questo suol, di tristi
Lochi e dal mondo abbandonati amante,
E d’afflitte fortune ognor compagna.
Questi campi cosparsi
Di ceneri infeconde, e ricoperti
Dell’impietrata lava,
Che sotto i passi al peregrin risona;
Dove s’annida e si contorce al sole
La serpe, e dove al noto
Cavernoso covil torna il coniglio;
Fur liete ville e colti,
E biondeggiàr di spiche, e risonaro
Di muggito d’armenti;
Fur giardini e palagi,
Agli ozi de’ potenti
Gradito ospizio; e fur città famose
Che coi torrenti suoi l’altero monte
Dall’ignea bocca fulminando oppresse
Con gli abitanti insieme. Or tutto intorno
Una ruina involve,
Dove tu siedi, o fior gentile, e quasi
I danni altrui commiserando, al cielo
Di dolcissimo odor mandi un profumo,
Che il deserto consola. A queste piagge
Venga colui che d’esaltar con lode
Il nostro stato ha in uso, e vegga quanto
E’ il gener nostro in cura
All’amante natura. E la possanza
Qui con giusta misura
Anco estimar potrà dell’uman seme,
Cui la dura nutrice, ov’ei men teme,
Con lieve moto in un momento annulla
In parte, e può con moti
Poco men lievi ancor subitamente
Annichilare in tutto.
Dipinte in queste rive
Son dell’umana gente
Le magnifiche sorti e progressive.Qui mira e qui ti specchia,
Secol superbo e sciocco,
Che il calle insino allora
Dal risorto pensier segnato innanti
Abbandonasti, e volti addietro i passi,
Del ritornar ti vanti,
E proceder il chiami.
Al tuo pargoleggiar gl’ingegni tutti,
Di cui lor sorte rea padre ti fece,
Vanno adulando, ancora
Ch’a ludibrio talora
T’abbian fra se. Non io
Con tal vergogna scenderò sotterra;
Ma il disprezzo piuttosto che si serra
Di te nel petto mio,
Mostrato avrò quanto si possa aperto:
Ben ch’io sappia che obblio
Preme chi troppo all’età propria increbbe.
Di questo mal, che teco
Mi fia comune, assai finor mi rido.
Libertà vai sognando, e servo a un tempo
Vuoi di novo il pensiero,
Sol per cui risorgemmo
Della barbarie in parte, e per cui solo
Si cresce in civiltà, che sola in meglio
Guida i pubblici fati.
Così ti spiacque il vero
Dell’aspra sorte e del depresso loco
Che natura ci diè. Per questo il tergo
Vigliaccamente rivolgesti al lume
Che il fe palese: e, fuggitivo, appelli
Vil chi lui segue, e solo
Magnanimo colui
Che se schernendo o gli altri, astuto o folle,
Fin sopra gli astri il mortal grado estolle.Uom di povero stato e membra inferme
Che sia dell’alma generoso ed alto,
Non chiama se nè stima
Ricco d’or nè gagliardo,
E di splendida vita o di valente
Persona infra la gente
Non fa risibil mostra;
Ma se di forza e di tesor mendico
Lascia parer senza vergogna, e noma
Parlando, apertamente, e di sue cose
Fa stima al vero uguale.
Magnanimo animale
Non credo io già, ma stolto,
Quel che nato a perir, nutrito in pene,
Dice, a goder son fatto,
E di fetido orgoglio
Empie le carte, eccelsi fati e nove
Felicità, quali il ciel tutto ignora,
Non pur quest’orbe, promettendo in terra
A popoli che un’onda
Di mar commosso, un fiato
D’aura maligna, un sotterraneo crollo
Distrugge sì, che avanza
A gran pena di lor la rimembranza.
Nobil natura è quella
Che a sollevar s’ardisce
Gli occhi mortali incontra
Al comun fato, e che con franca lingua,
Nulla al ver detraendo,
Confessa il mal che ci fu dato in sorte,
E il basso stato e frale;
Quella che grande e forte
Mostra se nel soffrir, nè gli odii e l’ire
Fraterne, ancor più gravi
D’ogni altro danno, accresce
Alle miserie sue, l’uomo incolpando
Del suo dolor, ma dà la colpa a quella
Che veramente è rea, che de’ mortali
Madre è di parto e di voler matrigna.
Costei chiama inimica; e incontro a questa
Congiunta esser pensando,
Siccome è il vero, ed ordinata in pria
L’umana compagnia,
Tutti fra se confederati estima
Gli uomini, e tutti abbraccia
Con vero amor, porgendo
Valida e pronta ed aspettando aita
Negli alterni perigli e nelle angosce
Della guerra comune. Ed alle offese
Dell’uomo armar la destra, e laccio porre
Al vicino ed inciampo,
Stolto crede così, qual fora in campo
Cinto d’oste contraria, in sul più vivo
Incalzar degli assalti,
Gl’inimici obbliando, acerbe gare
Imprender con gli amici,
E sparger fuga e fulminar col brando
Infra i propri guerrieri.
Così fatti pensieri
Quando fien, come fur, palesi al volgo,
E quell’orror che primo
Contra l’empia natura
Strinse i mortali in social catena,
Fia ricondotto in parte
Da verace saper, l’onesto e il retto
Conversar cittadino,
E giustizia e pietade, altra radice
Avranno allor che non superbe fole,
Ove fondata probità del volgo
Così star suole in piede
Quale star può quel ch’ha in error la sede.Sovente in queste rive,
Che, desolate, a bruno
Veste il flutto indurato, e par che ondeggi,
Seggo la notte; e sulla mesta landa
In purissimo azzurro
Veggo dall’alto fiammeggiar le stelle,
Cui di lontan fa specchio
Il mare, e tutto di scintille in giro
Per lo vòto Seren brillar il mondo.
E poi che gli occhi a quelle luci appunto,
Ch’a lor sembrano un punto,
E sono immense, in guisa
Che un punto a petto a lor son terra e mare
Veracemente; a cui
L’uomo non pur, ma questo
Globo ove l’uomo è nulla,
Sconosciuto è del tutto; e quando miro
Quegli ancor più senz’alcun fin remoti
Nodi quasi di stelle,
Ch’a noi paion qual nebbia, a cui non l’uomo
E non la terra sol, ma tutte in uno,
Del numero infinite e della mole,
Con l’aureo sole insiem, le nostre stelle
O sono ignote, o così paion come
Essi alla terra, un punto
Di luce nebulosa; al pensier mio
Che sembri allora, o prole
Dell’uomo? E rimembrando
Il tuo stato quaggiù, di cui fa segno
Il suol ch’io premo; e poi dall’altra parte,
Che te signora e fine
Credi tu data al Tutto, e quante volte
Favoleggiar ti piacque, in questo oscuro
Granel di sabbia, il qual di terra ha nome,
Per tua cagion, dell’universe cose
Scender gli autori, e conversar sovente
Co’ tuoi piacevolmente, e che i derisi
Sogni rinnovellando, ai saggi insulta
Fin la presente età, che in conoscenza
Ed in civil costume
Sembra tutte avanzar; qual moto allora,
Mortal prole infelice, o qual pensiero
Verso te finalmente il cor m’assale?
Non so se il riso o la pietà prevale.Come d’arbor cadendo un picciol pomo,
Cui là nel tardo autunno
Maturità senz’altra forza atterra,
D’un popol di formiche i dolci alberghi,
Cavati in molle gleba
Con gran lavoro, e l’opre
E le ricchezze che adunate a prova
Con lungo affaticar l’assidua gente
Avea provvidamente al tempo estivo,
Schiaccia, diserta e copre
In un punto; così d’alto piombando,
Dall’utero tonante
Scagliata al ciel, profondo
Di ceneri e di pomici e di sassi
Notte e ruina, infusa
Di bollenti ruscelli,
O pel montano fianco
Furiosa tra l’erba
Di liquefatti massi
E di metalli e d’infocata arena
Scendendo immensa piena,
Le cittadi che il mar là su l’estremo
Lido aspergea, confuse
E infranse e ricoperse
In pochi istanti: onde su quelle or pasce
La capra, e città nove
Sorgon dall’altra banda, a cui sgabello
Son le sepolte, e le prostrate mura
L’arduo monte al suo piè quasi calpesta.
Non ha natura al seme
Dell’uom più stima o cura
Che alla formica: e se più rara in quello
Che nell’altra è la strage,
Non avvien ciò d’altronde
Fuor che l’uom sue prosapie ha men feconde.Ben mille ed ottocento
Anni varcàr poi che spariro, oppressi
Dall’ignea forza, i popolati seggi,
E il villanello intento
Ai vigneti, che a stento in questi campi
Nutre la morta zolla e incenerita,
Ancor leva lo sguardo
Sospettoso alla vetta
Fatal, che nulla mai fatta più mite
Ancor siede tremenda, ancor minaccia
A lui strage ed ai figli ed agli averi
Lor poverelli. E spesso
Il meschino in sul tetto
Dell’ostel villereccio, alla vagante
Aura giacendo tutta notte insonne,
E balzando più volte, esplora il corso
Del temuto bollor, che si riversa
Dall’inesausto grembo
Sull’arenoso dorso, a cui riluce
Di Capri la marina
E di Napoli il porto e Mergellina.
E se appressar lo vede, o se nel cupo
Del domestico pozzo ode mai l’acqua
Fervendo gorgogliar, desta i figliuoli,
Desta la moglie in fretta, e via, con quanto
Di lor cose rapir posson, fuggendo,
Vede lontano l’usato
Suo nido, e il picciol campo,
Che gli fu dalla fame unico schermo,
Preda al flutto rovente
Che crepitando giunge, e inesorato
Durabilmente sovra quei si spiega.
Torna al celeste raggio
Dopo l’antica obblivion l’estinta
Pompei, come sepolto
Scheletro, cui di terra
Avarizia o pietà rende all’aperto;
E dal deserto foro
Diritto infra le file
Dei mozzi colonnati il peregrino
Lunge contempla il bipartito giogo
E la cresta fumante,
Ch’alla sparsa ruina ancor minaccia.
E nell’orror della secreta notte
Per li vacui teatri, per li templi
Deformi e per le rotte
Case, ove i parti il pipistrello asconde,
Come sinistra face
Che per voti palagi atra s’aggiri,
Corre il baglior della funerea lava,
Che di lontan per l’ombre
Rosseggia e i lochi intorno intorno tinge.
Così, dell’uomo ignara e dell’etadi
Ch’ei chiama antiche, e del seguir che fanno
Dopo gli avi i nepoti,
Sta natura ognor verde, anzi procede
Per sì lungo cammino,
Che sembra star. Caggiono i regni intanto,
Passan genti e linguaggi: ella nol vede:
E l’uom d’eternità s’arroga il vanto.E tu, lenta ginestra,
Che di selve odorate
Queste campagne dispogliate adorni,
Anche tu presto alla crudel possanza
Soccomberai del sotterraneo foco,
Che ritornando al loco
Già noto, stenderà l’avaro lembo
Su tue molli foreste. E piegherai
Sotto il fascio mortal non renitente
Il tuo capo innocente:
Ma non piegato insino allora indarno
Codardamente supplicando innanzi
Al futuro oppressor; ma non eretto
Con forsennato orgoglio inver le stelle,
Nè sul deserto, dove
E la sede e i natali
Non per voler ma per fortuna avesti;
Ma più saggia, ma tanto
Meno inferma dell’uom, quanto le frali
Tue stirpi non credesti
O dal fato o da te fatte immortali.
A un vincitore nel pallone
Di gloria il viso e la gioconda voce,
Garzon bennato, apprendi,
E quanto al femminile ozio sovrasti
La sudata virtude. Attendi attendi,
Magnanimo campion (s’alla veloce
Piena degli anni il tuo valor contrasti
La spoglia di tuo nome), attendi e il core
Movi ad alto desio. Te l’echeggiante
Arena e il circo, e te fremendo appella
Ai fatti illustri il popolar favore;
Te rigoglioso dell’età novella
Oggi la patria cara
Gli antichi esempi a rinnovar prepara.Del barbarico sangue in Maratona
Non colorò la destra
Quei che gli atleti ignudi e il campo eleo,
Che stupido mirò l’ardua palestra,
Né la palma beata e la corona
D’emula brama il punse. E nell’Alfeo
Forse le chiome polverose e i fianchi
Delle cavalle vincitrici asterse
Tal che le greche insegne e il greco acciaro
Guidò de’ Medi fuggitivi e stanchi
Nelle pallide torme; onde sonaro
Di sconsolato grido
L’alto sen dell’Eufrate e il servo lido.Vano dirai quel che disserra e scote
Della virtù nativa
Le riposte faville? e che del fioco
Spirto vital negli egri petti avviva
Il caduco fervor? Le meste rote
Da poi che Febo instiga, altro che gioco
Son l’opre de’ mortali? ed è men vano
Della menzogna il vero? A noi di lieti
Inganni e di felici ombre soccorse
Natura stessa: e là dove l’insano
Costume ai forti errori esca non porse,
Negli ozi oscuri e nudi
Mutò la gente i gloriosi studi.Tempo forse verrà ch’alle ruine
Delle italiche moli
Insultino gli armenti, e che l’aratro
Sentano i sette colli; e pochi Soli
Forse fien volti, e le città latine
Abiterà la cauta volpe, e l’atro
Bosco mormorerà fra le alte mura;
Se la funesta delle patrie cose
Obblivion dalle perverse menti
Non isgombrano i fati, e la matura
Clade non torce dalle abbiette genti
Il ciel fatto cortese
Dal rimembrar delle passate imprese.Alla patria infelice, o buon garzone,
Sopravviver ti doglia.
Chiaro per lei stato saresti allora
Che del serto fulgea, di ch’ella è spoglia,
Nostra colpa e fatal. Passò stagione;
Che nullo di tal madre oggi s’onora:
Ma per te stesso al polo ergi la mente.
Nostra vita a che val? solo a spregiarla:
Beata allor che ne’ perigli avvolta,
Se stessa obblia, nè delle putri e lente
Ore il danno misura e il flutto ascolta;
Beata allor che il piede
Spinto al varco leteo, più grata riede.
All’Italia
O patria mia, vedo le mura e gli archi
E le colonne e i simulacri e l’erme
Torri degli avi nostri,
Ma la gloria non vedo,
Non vedo il lauro e il ferro ond’eran carchi
I nostri padri antichi. Or fatta inerme,
Nuda la fronte e nudo il petto mostri.
Oimè quante ferite,
Che lividor, che sangue! oh qual ti veggio,
Formosissima donna! Io chiedo al cielo
E al mondo: dite dite;
Chi la ridusse a tale? E questo è peggio,
Che di catene ha carche ambe le braccia;
Sì che sparte le chiome e senza velo
Siede in terra negletta e sconsolata,
Nascondendo la faccia
Tra le ginocchia, e piange.
Piangi, che ben hai donde, Italia mia,
Le genti a vincer nata
E nella fausta sorte e nella ria.Se fosser gli occhi tuoi due fonti vive,
Mai non potrebbe il pianto
Adeguarsi al tuo danno ed allo scorno;
Che fosti donna, or sei povera ancella.
Chi di te parla o scrive,
Che, rimembrando il tuo passato vanto,
Non dica: già fu grande, or non è quella?
Perchè, perchè? dov’è la forza antica,
Dove l’armi e il valore e la costanza?
Chi ti discinse il brando?
Chi ti tradì? qual arte o qual fatica
O qual tanta possanza
Valse a spogliarti il manto e l’auree bende?
Come cadesti o quando
Da tanta altezza in così basso loco?
Nessun pugna per te? non ti difende
Nessun de’ tuoi? L’armi, qua l’armi: io solo
Combatterò, procomberò sol io.
Dammi, o ciel, che sia foco
Agl’italici petti il sangue mio.Dove sono i tuoi figli? Odo suon d’armi
E di carri e di voci e di timballi:
In estranie contrade
Pugnano i tuoi figliuoli.
Attendi, Italia, attendi. Io veggio, o parmi,
Un fluttuar di fanti e di cavalli,
E fumo e polve, e luccicar di spade
Come tra nebbia lampi.
Nè ti conforti? e i tremebondi lumi
Piegar non soffri al dubitoso evento?
A che pugna in quei campi
L’Itala gioventude? O numi, o numi:
Pugnan per altra terra itali acciari.
Oh misero colui che in guerra è spento,
Non per li patrii lidi e per la pia
Consorte e i figli cari,
Ma da nemici altrui,
Per altra gente, e non può dir morendo:
Alma terra natia,
La vita che mi desti ecco ti rendo.Oh venturose e care e benedette
L’antiche età, che a morte
Per la patria correan le genti a squadre;
E voi sempre onorate e gloriose,
O tessaliche strette,
Dove la Persia e il fato assai men forte
Fu di poch’alme franche e generose!
Io credo che le piante e i sassi e l’onda
E le montagne vostre al passeggere
Con indistinta voce
Narrin siccome tutta quella sponda
Coprìr le invitte schiere
De’ corpi ch’alla Grecia eran devoti.
Allor, vile e feroce,
Serse per l’Ellesponto si fuggia,
Fatto ludibrio agli ultimi nepoti;
E sul colle d’Antela, ove morendo
Si sottrasse da morte il santo stuolo,
Simonide salia,
Guardando l’etra e la marina e il suolo.E di lacrime sparso ambe le guance,
E il petto ansante, e vacillante il piede,
Toglieasi in man la lira:
Beatissimi voi,
Ch’offriste il petto alle nemiche lance
Per amor di costei ch’al Sol vi diede;
Voi che la Grecia cole, e il mondo ammira.
Nell’armi e ne’ perigli
Qual tanto amor le giovanette menti,
Qual nell’acerbo fato amor vi trasse?
Come sì lieta, o figli,
L’ora estrema vi parve, onde ridenti
Correste al passo lacrimoso e duro?
Parea ch’a danza e non a morte andasse
Ciascun de’ vostri, o a splendido convito:
Ma v’attendea lo scuro
Tartaro, e l’onda morta;
Nè le spose vi foro o i figli accanto
Quando su l’aspro lito
Senza baci moriste e senza pianto.Ma non senza de’ Persi orrida pena
Ed immortale angoscia.
Come lion di tori entro una mandra
Or salta a quello in tergo e sì gli scava
Con le zanne la schiena,
Or questo fianco addenta or quella coscia;
Tal fra le Perse torme infuriava
L’ira de’ greci petti e la virtute.
Ve’ cavalli supini e cavalieri;
Vedi intralciare ai vinti
La fuga i carri e le tende cadute,
E correr fra’ primieri
Pallido e scapigliato esso tiranno;
Ve’ come infusi e tinti
Del barbarico sangue i greci eroi,
Cagione ai Persi d’infinito affanno,
A poco a poco vinti dalle piaghe,
L’un sopra l’altro cade. Oh viva, oh viva:
Beatissimi voi
Mentre nel mondo si favelli o scriva.Prima divelte, in mar precipitando,
Spente nell’imo strideran le stelle,
Che la memoria e il vostro
Amor trascorra o scemi.
La vostra tomba è un’ara; e qua mostrando
Verran le madri ai parvoli le belle
Orme del vostro sangue. Ecco io mi prostro,
O benedetti, al suolo,
E bacio questi sassi e queste zolle,
Che fien lodate e chiare eternamente
Dall’uno all’altro polo.
Deh foss’io pur con voi qui sotto, e molle
Fosse del sangue mio quest’alma terra.
Che se il fato è diverso, e non consente
Ch’io per la Grecia i moribondi lumi
Chiuda prostrato in guerra,
Così la vereconda
Fama del vostro vate appo i futuri
Possa, volendo i numi,
Tanto durar quanto la vostra duri.
Consalvo
Presso alla fin di sua dimora in terra,
Giacea Consalvo; disdegnoso un tempo
Del suo destino; or già non più, che a mezzo
Il quinto lustro, gli pendea sul capo
Il sospirato obblio. Qual da gran tempo,
Così giacea nel funeral suo giorno
Dai più diletti amici abbandonato:
Ch’amico in terra al lungo andar nessuno
Resta a colui che della terra è schivo.
Pur gli era al fianco, da pietà condotta
A consolare il suo deserto stato,
Quella che sola e sempre eragli a mente,
Per divina beltà famosa Elvira;
Conscia del suo poter, conscia che un guardo
Suo lieto, un detto d’alcun dolce asperso,
Ben mille volte ripetuto e mille
Nel costante pensier, sostegno e cibo
Esser solea dell’infelice amante:
Benchè nulla d’amor parola udita
Avess’ella da lui. Sempre in quell’alma
Era del gran desio stato più forte
Un sovrano timor. Così l’avea
Fatto schiavo e fanciullo il troppo amore.Ma ruppe alfin la morte il nodo antico
Alla sua lingua. Poichè certi i segni
Sentendo di quel dì che l’uom discioglie,
Lei, già mossa a partir, presa per mano,
E quella man bianchissima stringendo,
Disse: tu parti, e l’ora omai ti sforza:
Elvira, addio. Non ti vedrò, ch’io creda,
Un’altra volta. Or dunque addio. Ti rendo
Qual maggior grazia mai delle tue cure
Dar possa il labbro mio. Premio daratti
Chi può, se premio ai pii dal ciel si rende.
Impallidia la bella, e il petto anelo
Udendo le si fea: che sempre stringe
All’uomo il cor dogliosamente, ancora
Ch’estranio sia, chi si diparte e dice,
Addio per sempre. E contraddir voleva,
Dissimulando l’appressar del fato,
Al moribondo. Ma il suo dir prevenne
Quegli, e soggiunse: desiata, e molto,
Come sai, ripregata a me discende,
Non temuta, la morte; e lieto apparmi
Questo feral mio dì. Pesami, è vero,
Che te perdo per sempre. Oimè per sempre
Parto da te. Mi si divide il core
In questo dir. Più non vedrò quegli occhi,
Nè la tua voce udrò! Dimmi: ma pria
Di lasciarmi in eterno, Elvira, un bacio
Non vorrai tu donarmi? un bacio solo
In tutto il viver mio? Grazia ch’ei chiegga
Non si nega a chi muor. Nè già vantarmi
Potrò del dono, io semispento, a cui
Straniera man le labbra oggi fra poco
Eternamente chiuderà. Ciò detto
Con un sospiro, all’adorata destra
Le fredde labbra supplicando affisse.Stette sospesa e pensierosa in atto
La bellissima donna; e fiso il guardo,
Di mille vezzi sfavillante, in quello
Tenea dell’infelice, ove l’estrema
Lacrima rilucea. Nè dielle il core
Di sprezzar la dimanda, e il mesto addio
Rinacerbir col niego; anzi la vinse
Misericordia dei ben noti ardori.
E quel volto celeste, e quella bocca,
Già tanto desiata, e per molt’anni
Argomento di sogno e di sospiro,
Dolcemente appressando al volto afflitto
E scolorato dal mortale affanno,
Più baci e più, tutta benigna e in vista
D’alta pietà, su le convulse labbra
Del trepido, rapito amante impresse.Che divenisti allor? quali appariro
Vita, morte, sventura agli occhi tuoi,
Fuggitivo Consalvo? Egli la mano,
Ch’ancor tenea, della diletta Elvira
Postasi al cor, che gli ultimi battea
Palpiti della morte e dell’amore,
Oh, disse, Elvira, Elvira mia! ben sono
In su la terra ancor; ben quelle labbra
Fur le tue labbra, e la tua mano io stringo!
Ahi vision d’estinto, o sogno, o cosa
Incredibil mi par. Deh quanto, Elvira,
Quanto debbo alla morte! Ascoso innanzi
Non ti fu l’amor mio per alcun tempo;
Non a te, non altrui; che non si cela
Vero amore alla terra. Assai palese
Agli atti, al volto sbigottito, agli occhi,
Ti fu: ma non ai detti. Ancora e sempre
Muto sarebbe l’infinito affetto
Che governa il cor mio, se non l’avesse
Fatto ardito il morir. Morrò contento
Del mio destino omai, nè più mi dolgo
Ch’aprii le luci al dì. Non vissi indarno,
Poscia che quella bocca alla mia bocca
Premer fu dato. Anzi felice estimo
La sorte mia. Due cose belle ha il mondo:
Amore e morte. All’una il ciel mi guida
In sul fior dell’età; nell’altro, assai
Fortunato mi tengo. Ah, se una volta,
Solo una volta il lungo amor quieto
E pago avessi tu, fora la terra
Fatta quindi per sempre un paradiso
Ai cangiati occhi miei. Fin la vecchiezza,
L’abborrita vecchiezza, avrei sofferto
Con riposato cor: che a sostentarla
Bastato sempre il rimembrar sarebbe
D’un solo istante, e il dir: felice io fui
Sovra tutti i felici. Ahi, ma cotanto
Esser beato non consente il cielo
A natura terrena. Amar tant’oltre
Non è dato con gioia. E ben per patto
In poter del carnefice ai flagelli,
Alle ruote, alle faci ito volando
Sarei dalle tue braccia; e ben disceso
Nel paventato sempiterno scempio.O Elvira, Elvira, oh lui felice, oh sovra
Gl’immortali beato, a cui tu schiuda
Il sorriso d’amor! felice appresso
Chi per te sparga con la vita il sangue!
Lice, lice al mortal, non è già sogno
Come stimai gran tempo, ahi lice in terra
Provar felicità. Ciò seppi il giorno
Che fiso io ti mirai. Ben per mia morte
Questo m’accadde. E non però quel giorno
Con certo cor giammai, fra tante ambasce,
Quel fiero giorno biasimar sostenni.Or tu vivi beata, e il mondo abbella,
Elvira mia, col tuo sembiante. Alcuno
Non l’amerà quant’io l’amai. Non nasce
Un altrettale amor. Quanto, deh quanto
Dal misero Consalvo in sì gran tempo
Chiamata fosti, e lamentata, e pianta!
Come al nome d’Elvira, in cor gelando,
Impallidir; come tremar son uso
All’amaro calcar della tua soglia,
A quella voce angelica, all’aspetto
Di quella fronte, io ch’al morir non tremo!
Ma la lena e la vita or vengon meno
Agli accenti d’amor. Passato è il tempo,
Nè questo dì rimemorar m’è dato.
Elvira, addio. Con la vital favilla
La tua diletta immagine si parte
Dal mio cor finalmente. Addio. Se grave
Non ti fu quest’affetto, al mio feretro
Dimani all’annottar manda un sospiro.
Tacque: nè molto andò, che a lui col suono
Mancò lo spirto; e innanzi sera il primo
Suo dì felice gli fuggia dal guardo.
Ultimo canto di saffo
Questa non può non essere annoverata tra le poesie più belle di Leopardi.
Placida notte, e verecondo raggio
Della cadente luna; e tu che spunti
Fra la tacita selva in su la rupe,
Nunzio del giorno; oh dilettose e care
Mentre ignote mi fur l’erinni e il fato,
Sembianze agli occhi miei; già non arride
Spettacol molle ai disperati affetti.
Noi l’insueto allor gaudio ravviva
Quando per l’etra liquido si volve
E per li campi trepidanti il flutto
Polveroso de’ Noti, e quando il carro,
Grave carro di Giove a noi sul capo,
Tonando, il tenebroso aere divide.
Noi per le balze e le profonde valli
Natar giova tra’ nembi, e noi la vasta
Fuga de’ greggi sbigottiti, o d’alto
Fiume alla dubbia sponda
Il suono e la vittrice ira dell’onda.Bello il tuo manto, o divo cielo, e bella
Sei tu, rorida terra. Ahi di cotesta
Infinita beltà parte nessuna
Alla misera Saffo i numi e l’empia
Sorte non fenno. A’ tuoi superbi regni
Vile, o natura, e grave ospite addetta,
E dispregiata amante, alle vezzose
Tue forme il core e le pupille invano
Supplichevole intendo. A me non ride
L’aprico margo, e dall’eterea porta
Il mattutino albor; me non il canto
De’ colorati augelli, e non de’ faggi
Il murmure saluta: e dove all’ombra
Degl’inchinati salici dispiega
Candido rivo il puro seno, al mio
Lubrico piè le flessuose linfe
Disdegnando sottragge,
E preme in fuga l’odorate spiagge.Qual fallo mai, qual sì nefando eccesso
Macchiommi anzi il natale, onde sì torvo
Il ciel mi fosse e di fortuna il volto?
In che peccai bambina, allor che ignara
Di misfatto è la vita, onde poi scemo
Di giovanezza, e disfiorato, al fuso
Dell’indomita Parca si volvesse
Il ferrigno mio stame? Incaute voci
Spande il tuo labbro: i destinati eventi
Move arcano consiglio. Arcano è tutto,
Fuor che il nostro dolor. Negletta prole
Nascemmo al pianto, e la ragione in grembo
De’ celesti si posa. Oh cure, oh speme
De’ più verd’anni! Alle sembianze il Padre,
Alle amene sembianze eterno regno
Diè nelle genti; e per virili imprese,
Per dotta lira o canto,
Virtù non luce in disadorno ammanto.Morremo. Il velo indegno a terra sparto,
Rifuggirà l’ignudo animo a Dite,
E il crudo fallo emenderà del cieco
Dispensator de’ casi. E tu cui lungo
Amore indarno, e lunga fede, e vano
D’implacato desio furor mi strinse,
Vivi felice, se felice in terra
Visse nato mortal. Me non asperse
Del soave licor del doglio avaro
Giove, poi che perìr gl’inganni e il sogno
Della mia fanciullezza. Ogni più lieto
Giorno di nostra età primo s’invola.
Sottentra il morbo, e la vecchiezza, e l’ombra
Della gelida morte. Ecco di tante
Sperate palme e dilettosi errori,
Il Tartaro m’avanza; e il prode ingegno
Han la tenaria Diva,
E l’atra notte, e la silente riva.
Alla sua donna
Cara beltà che amore
Lunge m’inspiri o nascondendo il viso,
Fuor se nel sonno il core
Ombra diva mi scuoti,
O ne’ campi ove splenda
Più vago il giorno e di natura il riso;
Forse tu l’innocente
Secol beasti che dall’oro ha nome,
Or leve intra la gente
Anima voli? o te la sorte avara
Ch’a noi t’asconde, agli avvenir prepara?Viva mirarti omai
Nulla speme m’avanza;
S’allor non fosse, allor che ignudo e solo
Per novo calle a peregrina stanza
Verrà lo spirto mio. Già sul novello
Aprir di mia giornata incerta e bruna,
Te viatrice in questo arido suolo
Io mi pensai. Ma non è cosa in terra
Che ti somigli; e s’anco pari alcuna
Ti fosse al volto, agli atti, alla favella,
Saria, così conforme, assai men bella.Fra cotanto dolore
Quanto all’umana età propose il fato,
Se vera e quale il mio pensier ti pinge,
Alcun t’amasse in terra, a lui pur fora
Questo viver beato:
E ben chiaro vegg’io siccome ancora
Seguir loda e virtù qual ne’ prim’anni
L’amor tuo mi farebbe. Or non aggiunse
Il ciel nullo conforto ai nostri affanni;
E teco la mortal vita saria
Simile a quella che nel cielo india.Per le valli, ove suona
Del faticoso agricoltore il canto,
Ed io seggo e mi lagno
Del giovanile error che m’abbandona;
E per li poggi, ov’io rimembro e piagno
I perduti desiri, e la perduta
Speme de’ giorni miei; di te pensando,
A palpitar mi sveglio. E potess’io,
Nel secol tetro e in questo aer nefando,
L’alta specie serbar; che dell’imago,
Poi che del ver m’è tolto, assai m’appago.Se dell’eterne idee
L’una sei tu, cui di sensibil forma
Sdegni l’eterno senno esser vestita,
E fra caduche spoglie
Provar gli affanni di funerea vita;
O s’altra terra ne’ superni giri
Fra’ mondi innumerabili t’accoglie,
E più vaga del Sol prossima stella
T’irraggia, e più benigno etere spiri;
Di qua dove son gli anni infausti e brevi,
Questo d’ignoto amante inno ricevi.
Quale preferisci tra le poesie di Leopardi?
Qual è la tua preferita tra le poesie di Leopardi? Se riesci a sceglierne una! Puoi scriverlo nei commenti. Magari spiega anche il perché, anche con una breve analisi, etc…
Inoltre, qual è la tua fase preferita del pensiero di Leopardi? Personalmente, benché ne apprezzi molto il pensiero filosofico e lo condivida pure in parte, non riesco a liberarmi della mia voglia di vivere e gioire. La natura non deve per forza essere una madre malvagia o indifferente. La natura è imprevedibile, ma è parte del suo fascino.




LA POESIA PIU’ BELLA DI LEOPARDI, PER I GUSTI MIEI, E’ – IN ASSOLUTO – L’INFINITO. L’UOMO DIFRONTE ALL’INDEFINITO. GRANDIOSITA’ E FINITEZZA. GLI INTERROGATIVI PIU’ INTIMI DI CIASCUN ESSERE UMANO, FEMMINA MASCHIO. INFINE, C’E’ LA RESA CONSAPEVOLE DELLA FRAGILITA’ UMANA. E. COME CURA, LEOPARDI, L’UMANA INADEGUATEZZA? LASCIANDOSI TRAVOLGERE, E PURE DOLCEMENTE, DAL MOTO ONDOSO DEL MARE DELLA VITA. (CHE RESTI TRA DI NOI)