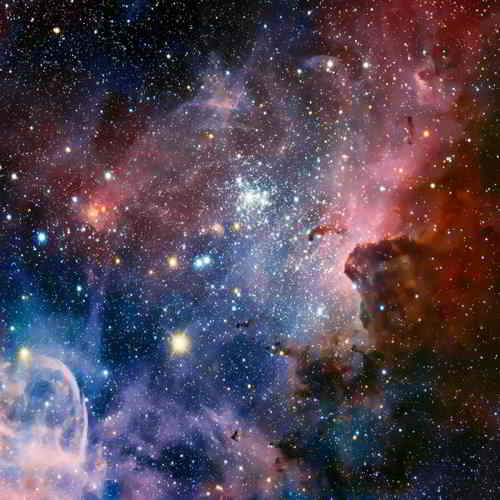Entrando, mi lascio alle spalle la visione d’insieme dell’Istituto, lì nella sua posizione privilegiata, adagiato sul crinale della collina dove la roccia è stata tagliata di netto per far spazio alla costruzione. Da un lato la strada che arriva con curve dolci, quasi inavvertibili, dall’altro la grande vallata dove i due laghetti si accaparrano l’attenzione sia di chi li vede per la prima volta e sia di chi, attorno, ci vive da una vita.
Chiudo dietro di me la porta dell’ingresso principale, salgo la rampa di scale, affronto il corridoio e, anche stavolta, meccanicamente la mano solleva la sciarpa a coprire il naso: beato l’inverno e l’alibi del freddo. Dopo mesi e mesi no, all’odore ancora non ci si abitua. Mi schiaccio contro la parete per far passare Elvise, col suo carrello traboccante di medicinali: è arrivato da poco da un punto dell’Italia dove non ha mai avvertito il freddo che c’è qui, e non solo nel clima, mi ha detto un giorno.
Prima di arrivare a metà corridoio, non posso non fermarmi a salutare Giacomo.
– Come va oggi?
– Eh, non ci si può lamentare. Stamattina mi hanno fatto il bagno e mi hanno dato il pandoro. Si tira avanti. Non mi posso lamentare; mi dispiace solo di non poter partecipare al mio funerale! Cosa non farei per vedere i nipoti accapigliarsi per quel po’ di soldi che avranno.
Ride, con la bocca sdentata, e ti fa ridere: i soldi ritornano puntuali nei suoi discorsi, poi aggiunge convinto che lui qui, all’Istituto non paga niente perché conosce il direttore. Proprio l’altro giorno uno dei nipoti mi diceva che hanno chiesto di trasferirlo in una struttura meno onerosa perché non ce la fanno più con le rette. Giacomo non sa che, uno dei prossimi giorni, si vedrà togliere questo mondo con cui è riuscito a venire a patti e se ne andrà altrove, col suo carico di poveri stracci che con i lavaggi della lavanderia esterna hanno assunto quel colore verdastro che accomuna ormai l’abbigliamento di tutti gli ospiti.
Dal salottino attiguo al corridoio si sente la voce calma di Katia, l’animatrice, colei che anima l’inanimato, penso io.
– E dopo la frutta dell’inverno, ricordiamo insieme quella dell’estate. Cominciamo da un frutto succoso, grande, rosso, coi chicchi neri. Chi indovina?
Qualcuno dei presenti, quasi tutti sulle sedie a rotelle, radunati attorno al tavolo, cincischia qualche parola. Prontamente Katia offre un supporto, linguistico stavolta: – Inizia con la A.
Ad un certo punto Maria, forse memore dei suoi lontani giorni di scuola quando alla maestra qualche risposta bisognava darla, sennò erano bacchettate sulle mani, con un guizzo azzardato fa entrare anche “anatra” nel mondo dei vegetali.
Helen, un’operatrice, mi saluta col suo sorriso che niente riesce a scalfire. Ho capito, anche se non me l’ha mai detto, che nelle pur scarse ore di formazione che le hanno permesso questo lavoro, quelle che riguardavano la pazienza, il rispetto dei vecchi a lei non servivano: nulla avrebbero potuto aggiungere alla sua etica inattaccabile, a ciò che è già intessuto nella sua persona, nella sua tradizione, nella cultura del paese africano da cui proviene e di cui a volte, quando ha un po’ di tempo, mi parla con il luccichio negli occhi.
– Buongiorno Helen! Mia mamma?
– E’ nel salottino piccolo in fondo, mi sembra meglio di ieri. Buona giornata!
Ancora pochi metri, ma prima di arrivarci mi imbatto in Lucina. E’ formidabile, la sua mente è riuscita a ricostruire qui dentro una nuova vita immaginaria: quel suo povero marito, ormai sepolto da una ventina d’anni, ha trovato la reincarnazione in uno degli ospiti dell’Istituto, Giosuè. E così quest’ultimo si è visto togliere la sua identità, il suo nome; Lucina gli ha appioppato quello della buonanima defunta e se lo trascina di qua e di là, sistemandogli la felpa, tenendolo per mano e chiedendogli democraticamente cosa desidera che gli prepari per cena.
Sulla soglia del salottino quasi mi scontro con Enrico, l’operatore sul cui volto mi piacerebbe almeno ogni tanto vedere l’ombra di un sorriso; mi chiedo spesso se sia stato questo luogo, con i suoi rituali, l’occuparsi delle più infime, sporche necessità dei corpi umani a renderlo così indifferente, a rivolgersi a queste anime con astio mai dissimulato o se fosse stato così anche prima, quando i suoi sogni prevedevano un lavoro diverso. Non potendo avere una risposta, propendo dentro di me per la seconda ipotesi.
Eccomi, cerco con gli occhi mia madre tra gli altri: è lì che piega e ripiega un angolo della tovaglietta, mi avvicino, la chiamo, solleva la testa, mi guarda ma non vede me. Quella maledetta malattia, dal nome duro, anche se le vocali dolci cercano di annientare il peso delle consonanti, si è presa tutto di lei: prima un po’ del tempo e dello spazio, poi ha allungato le mani sulla capacità di far fronte alle più banali azioni quotidiane, le ha nascosto le figlie che non erano più le sue figlie, ma estranee sospette, le ha artigliato i pensieri, le ha strappato i passi, le ha tolto ogni luce: dagli occhi e dall’anima.
– Mamma, sono io.
Quando si rinuncia a sperare nei miracoli, fosse anche solo quello di una risposta, di un guizzo nello sguardo, di un ricordo riportato alla memoria?
Ad un tratto arriva lui, puntuale come ogni giorno: è il marito di Ada. Non so se lei lo riconosca. Vengo attirata da ciò che oggi ciò lui stringe tra le le mani: un mazzolino di gerbere, alcune già pericolosamente inclinate, forse abita lontano da qui, mi dico; gliele consegna col fare maldestro degli adolescenti, accompagnato da un sussurro che leggo nelle labbra più avvertire nel suono: – Auguri amore mio.
Chissà se è il compleanno di Ada, oppure se sia il loro anniversario di matrimonio; sarà indiscrezione ma non riesco a distogliere lo sguardo, sono calamitata da quella tenerezza da struggimento, quasi inafferrabile nell’espressione di lei, ma solida, incrollabile in quella di lui, indifferente alle prese in giro della vita. Continuo a seguirli con gli occhi; si allontanano, mano nella mano. Mi sbaglio o anche Enrico si è fermato ad osservarli dall’altro lato del corridoio? Forse è solo la mia commozione che credo di intravvedere anche negli altri.
Faccio alzare mia madre dalla sedia, le sistemo i piedi, glieli metto in posizione di partenza perché anche se fa fatica bisogna mantenerle le abitudini e quella del camminare è importante perché allontana altre conseguenze che fanno parte della malattia. Ci avviamo per il corridoio, lei appesa completamente al mio braccio; ogni tanto dobbiamo fermarci e penso che senso abbia insistere, aggiungere doveri in questa sua vita non-vita. Raggiungiamo un divanetto dove lei sprofonda; mi tocca la collana, poi l’attenzione è attirata dal mio orologio, prova a sfilarmelo.
Inizio una litania di parole: bachi da seta, erba,fieno, prati, nomi propri della sua famiglia. Niente suscita niente, neanche l’idea di un pensiero fuggevole che si appenda lì nel suo vecchio mondo dove vorrei riportarla anche solo per un attimo.
Ritorniamo al salottino sempre più stancamente, la affido ad un operatore; so che saranno mani estranee ad occuparsi di mia madre, manipoleranno quel corpo scheletrico, la imboccheranno, la prepareranno per la notte. La saluto con una carezza appena sfiorata perché non voglio sentire le ossa che, prepotenti, sembrano voler lacerare quel velo di pelle ogni settimana più trasparente.
Rifaccio il percorso al contrario, sono fuori, mi richiudo alle spalle la porta dell’ingresso principale; una sferzata di aria imprevista, quasi feroce, mi investe: abbasso la sciarpa più che posso e lascio che mi aggredisca fino in fondo, voglio respirarla a pieni polmoni.
Loretta Casagrande